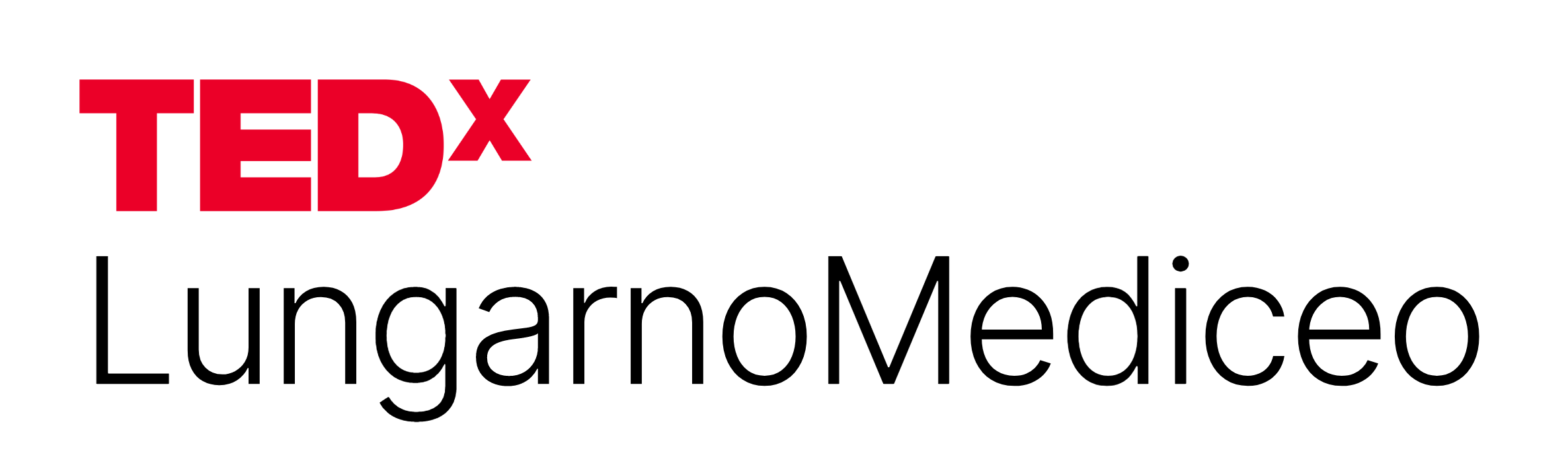Me ne frego dei tuoi diritti: il privilegio di aiutare | Beatrice Marzi
A 17 anni io ho scoperto cosa fossero i diritti umani. Ho scoperto cosa volesse dire sentirsene privati e sentirsi vulnerabili. A 17 anni infatti ho vissuto il terremoto dell’Aquila e per qualche giorno dopo il 6 Aprile 2009 non avevo altro se non il diritto ad essere soccorsa, anche se non sempre secondo i miei bisogni. In quei giorni si sono create delle comunità all’interno della comunità, dei micromondi. Ognuno portava avanti la causa del gruppo al quale apparteneva e le differenze tra i diversi micromondi erano ben visibili. Poi si è creata un’altra comunità, una bolla che ci ha circondato, ovvero l’aiuto proveniente dall’esterno. Infatti in quei giorni, nella mia città, si sono riversati migliaia di persone, professionisti e volontari, tutti con un unico nobile obiettivo: quello di aiutare degli sconosciuti in difficoltà. Degli sconosciuti.
Ecco, nello stesso momento si è andata a delineare una differenza, uno squilibrio tra chi soccorreva e chi era soccorso. Una strana co-dipendenza che poi ho rivisto infinite volte durante le mie esperienze di lavoro nel sud globale, in paesi dove chi soccorre si sente investito del diritto di parlare per chi è soccorso, e quest’ultimo lo legittima tacitamente. Di fatto andando a dare qualcosa indietro al soccorritore. Perché comunque dobbiamo ricordare che anche aiutare è una manifestazione del potere.
Il potere può assumere diverse forme e credo che al giorno d’oggi ci rendiamo ancora troppo poco conto dell’importanza del potere della comunicazione soprattutto in alcuni ambiti. I moderni concetti di povertà, sviluppo, paesi in via di sviluppo sono stati plasmati durante gli anni ’80. Un periodo di forti crisi globali caratterizzati da una grande presenza mediatica e da una strumentalizzazione politica dell’aiuto umanitario. Il caso dell’Etiopia diventa un esempio lampante di una crisi locale e di una campagna di sensibilizzazione portata a vanti su scala globale dai media e da artisti di grandissima fama che organizzano il primo concerto trasmesso internazionalmente in televisione, ovvero il Live Aid. Con l’unico obiettivo di salvare l’Africa, sfamare l’Africa.
Ecco questo oltre a creare i primi stereotipi sul continente africano inteso come continente povero in realtà porta la sofferenza umana di paesi molto lontani nella casa di tutti noi. La porta sotto gli occhi di tutti, la dà in pasto ad un ampio pubblico, senza però fornire gli strumenti per comprendere le cause alla base di questa crisi. Di queste crisi. Ecco, il problema è che in quei giorni ci si chiede “Per quale motivo muore così tanta gente di fame in Etiopia?”, “Ma perché l’Etiopia è un paese sfortunato, è un paese sottosviluppato, è un paese africano” dei concetti orribili. In realtà il discorso è che ci sono delle implicazioni geopolitiche connesse alla decolonizzazione, alla guerra fredda, ma sono troppo complesse per essere standardizzate, trasformate in slogan. Utilizzare degli stereotipi ci avvicina ad un problema, però quello che rischiamo è che lo analizziamo solo da un punto di vista superficiale. E, l’altro problema, l’altro effetto collaterale è che ci ammaliamo di quella che si chiama la sindrome dello spettatore della sofferenza. Siamo tutti spettatori della sofferenza. Lo spettatore della sofferenza è nel sicuro nella propria casa e attraverso uno schermo assiste a delle immagini devastanti, strazianti di povertà, freddo, fame, guerre, bombe, morte in paesi però lontani. E viene bombardato talmente tanto di queste immagini che si sente sopraffatto, si sente esausto. È come se guardasse lo stesso film per l’ennesima volta, sa già come comincerà e come andrà a finire, e si sente quasi infastidito. Infatti ci siamo sentiti tutti quasi infastiditi davanti alle pubblicità delle grandi organizzazioni umanitarie che ci mostrano il piccolo Nirob, che muore di fame in Kenya, coperto di mosche, spogliato della sua dignità. E noi cosa possiamo farci? Niente.
Oppure, al contrario, la comunicazione umanitaria ci dà uno strano senso di onnipotenza perché fornisce delle risposte molto semplici a dei problemi molto complessi che tra l’altro ci fanno sentire inutili. Con 12 centesimi al giorno puoi salvare la vita di un bambino in Mali. Per te 12 centesimi non sono nulla per lui la vita. Ed ecco che andiamo a svalutare l’importanza dell’aiuto umanitario, con 12 centesimi non si offre un supporto di un certo livello ad una popolazione in difficoltà. E contemporaneamente ci convinciamo del fatto che basta poco per fare tanto. E non c’è niente di più sbagliato perché così noi diamo un valore diverso, minore, alla sofferenza degli altri. E noi stessi viviamo in una visione egocentrica.
Io stessa sono partita per l’India per la prima volta a 19 anni, avevo la testa piena di preconcetti sulla povertà, lo sviluppo. E mi sentivo sopraffatta per la maggior parte del tempo. Provavo anche un enorme senso di colpa ovviamente nel sentirmi una privilegiata e mi sembrava di appropriarmi della sofferenza di altri stando male. Ecco, mossa da questo senso di colpa costante cercavo di aiutare in maniera indiscriminata commettendo solo errori. Infatti, regalare dei soldi ad un bambino di 7 anni che ti dice di vivere per strada non lo aiuta, non gli cambia la vita, anzi lo convince del fatto che se vuole solo sopravvivere non deve ambire a niente di meglio. Troverà sempre qualcuno che gli darà dei soldi, magari un europeo per cui 12 centesimi non sono nulla. Ecco, questo è un grandissimo problema anche perché spesso si parte per fare volontariato in paesi in via di sviluppo, o si va a lavorare per organizzazioni in paesi in via di sviluppo senza avere le competenze e questo non fortifica né la comunità né l’organizzazione. Infatti quando noi aiutiamo qualcuno la prima cosa che dovremmo chiederci è “Di cosa hai bisogno tu?”, e solo dopo “Cosa posso fare io?”, non il contrario. Perché aiutare vuol dire rispondere ad un bisogno specifico, non calare qualcosa dall’alto. Io questo l’ho imparato sbagliando e osservare gli altri sbagliare. Infatti cos’è che mette in dubbio le nostre convinzioni? È l’esperienza inaspettata oppure l’errore. Ci mette in crisi, ci mette in discussione. Noi qui pensiamo di avere, cioè siamo convinti di avere, abbastanza strumenti per informarci. Abbiamo selezionato una serie di canali, l’autore, l’articolo di giornale, anche il contesto culturale al quale apparteniamo e siamo convinti per la maggior parte del tempo di avere ragione perché abbiamo selezionato le informazioni giuste. Questo ovviamente non è possibile, noi non possiamo avere sempre ragione. C’è sempre spazio per spingere la nostra zona di comfort un po’ più in là e per apprendere qualcosa di nuovo, per entrare in crisi.
Io sono stata beneficiaria di un intervento di emergenza per diverse settimane e ho imparato qualcosa che non avrei assolutamente potuto apprendere dallo studio della teoria. Poi mi sono spostata sul campo, quindi passando dall’altro lato e ho capito quali fossero le delicatissime implicazioni che si nascondono dietro questo rapporto, questo binomio soccorritore-beneficiario. È molto difficile avere un rapporto equilibrato quando si rivestono dei ruoli che sono dettati dal contesto politico, sociale, geografico, economico. E spesso si parte anche da un altro presupposto sbagliato, ovvero che chi è in uno stato enorme necessità di essere aiutato accetterà qualsiasi forma di aiuto.
Ma questo non è vero, anzi chi è in uno stato di grande necessità deve volere il meglio perché una catastrofe non elimina la dignità di un essere umano anzi la rafforza. Se vengo colpita da una guerra, se vivo in uno stato di grande povertà, se perdo la casa in un terremoto io non devo accontentarmi delle briciole, io devo volere il meglio per me per la mia famiglia per la mia comunità. E quindi chi è sul campo, chi aiuta, deve dare il meglio, deve dare quello che darebbe a sé stesso, alla sua famiglia, alla sua comunità. Se in Siria c’è la guerra e non esistono scuole questo non mi giustifica nel costruire una struttura fatiscente perché tanto è meglio di niente. Un ragazzo che scappa dal Mali o dall’Afghanistan e arriva in Europa non deve accontentarsi di vivere in un hotspot infernale perché tanto è meglio di niente. Se io perdo la casa in un terremoto non devo accontentarmi di vivere in una tenda per settimane perché tanto è meglio di niente. Il concetto del “è meglio di niente” così come “il basta poco per fare tanto” deve scomparire dal panorama dell’aiuto locale ed internazionale e noi abbiamo il dovere di interrompere questo meccanismo, di dire di no, e ci dobbiamo mettere in testa che aiutare è difficile, richiede tempo e richiede competenze. Il concetto di compassione, il dovere morale connesso all’alleviare le sofferenze altrui è passato negli ultimi due secoli da una dimensione privata, quindi io aiuto te, ad una dimensione internazionale, pubblica, quindi uno stato aiuta un altro stato. Un’organizzazione umanitaria aiuta una comunità e di fatto ha preso delle connotazioni politiche. Creando nuove categorie, nuovi doveri, nuovi diritti. I diritti infatti sono un concetto artificiale, non sono presenti in natura, sono qualcosa che è stato sintetizzato, e noi dobbiamo renderci conto che la nostra società evolve e muta e nel 2050 esisteranno nuovi diritti. Nonostante quelli fondamentali ovviamente siano inviolabili. Ecco, chi ha sintetizzato i diritti umani è partito dal presupposto per cui, nonostante le differenti architetture culturali che caratterizzano le nostre società ci sia un filo rosso, un qualcosa che ci lega, una bellezza vulnerabile, una verità: la libertà, la libertà di vivere dignitosamente. Che è un diritto negato alla maggior parte della popolazione mondiale proprio perché è profondamente connesso a dei sistemi politici che poggiano i propri equilibri su dei meccanismi che sono folli, che sono crudeli e che perpetuano la disuguaglianza, la povertà, la guerra. Ed è per questo che noi non possiamo delegare il rispetto dei diritti umani a quegli stati che li calpestano. Per i diritti umani dobbiamo lottare tutti ma non in un’ottica egoista ovvero pensando che domani potrebbe succedere a noi perché tanto alla maggior parte di noi non succederà mai. Noi dobbiamo lottare per i diritti umani perché sono universali, altrimenti, come disse un pioniere del settore, sarebbero solo il privilegio di pochi.
Allora perché non lottiamo? Non lottiamo perché ci sentiamo schiacciati, perché ci sentiamo inutili per via della comunicazione umanitaria e perché pensiamo che il problema è lontano da casa nostra quindi non ci riguarda. Questo ovviamente non è vero. Però far parte di quella bolla che ha circondato l’Aquila nel 2009 è un privilegio. È il privilegio di avere gli strumenti e di essere nella posizione di migliorare la vita a qualcuno che è in difficoltà e quindi come tale va esercitato. Noi dobbiamo costruire la nostra coscienza critica quotidianamente e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per lottare per noi stessi e per gli altri. L’advocacy è uno di quegli strumenti. L’advocacy è un termine inglese che deriva dal verbo “to advocate” che vuol dire farsi promotore delle cause degli altri. È come dire che io ho gli strumenti, tu hai il problema e insieme cooperiamo affinché io risolva il problema tuo e della tua comunità a un livello politico, a un livello sistemico ovviamente. Per fare advocacy ci vuole una grandissima passione e soprattutto bisogna avere ben chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Questa sono io durante la mia prima campagna di advocacy a 19 anni e come potete vedere il mio strumento di battaglia è una carriola, una carriola per fare giardinaggio. Il bello dell’advocacy infatti è che trasforma ogni oggetto in uno strumento e ogni strumento in una potenziale campagna di sensibilizzazione. Noi all’epoca ci eravamo messi in testa di svuotare la città dell’Aquila dalle macerie. Ovviamente un’idea folle, ma l’obbiettivo era quello di riportare l’attenzione mediatica su un problema che lentamente stava passando in secondo piano e noi volevamo dire che c’eravamo e che avremmo lottato per quell’obiettivo. Questo in realtà è anche un esempio per dire che la maggior parte di noi può lottare per i propri diritti. La maggior parte di noi non deve fare uno sforzo eccessivo per essere compreso e per essere rispettato. O meglio, può, ci saranno sicuramente degli ostacoli degli impedimenti ma può utilizzare la propria voce. È per questo che l’advocacy è importante. Perché la maggior parte della popolazione mondiale questo diritto non ce l’ha. Non ha il diritto di esercitare la propria voce, di farsi ascoltare, quindi l’advocacy è importante per chi non ha questi diritti, per chi non ha quella voce. È quello che ci permette di ricreare un ponte tra noi soccorritori e i beneficiari. E ci permette di chiedere a loro di esprimere i loro bisogni.
Quindi il discorso qui è che, una tesi che non viene accettata da tutti, ma il mondo sta cambiando e le lotte sono cambiate rispetto agli anni ’70 quando l’apoteosi dell’aiuto umanitario era raffigurata dall’operatore sul campo che consegnava i pacchi di riso alla popolazione affamata. Se vuoi il riso o non vuoi il riso, non fa niente, ti becchi il riso. Ecco adesso è cambiato un poco questo approccio e non è molto apprezzato diciamo nella cooperazione contemporanea. E soprattutto c’è bisogno di andare incontro al beneficiario e di fare in modo che lui/lei esprima le proprie necessità. È cambiata la società? Siamo nell’epoca della connettografia, quindi i confini hanno lasciato spazio alle connessioni e quindi abbiamo dei nuovi strumenti per cambiare le cose. Non dobbiamo per forza essere sul campo, oggi possiamo cambiare le cose dal divano di casa. Spettatore della sofferenza che si risveglia un attimo e cerca di fare qualcosa. Allora cosa possiamo fare? Per prima cosa dobbiamo “informarci”. Si parte dall’inizio, si parte sempre dallo studio. È complesso, richiede tempo, dobbiamo analizzare le fonti, dobbiamo studiare, dobbiamo perderci tanto tempo però per forza da lì dobbiamo partire per analizzare un problema. Ovviamente non sto parlando dell’aprire il link sulla piattaforma digitale, tempo di lettura massimo stimato: 4 minuti. Quello non è informarsi, quello è semplificare e ci ricolleghiamo al discorso degli stereotipi che non ci aiutano a comprendere la realtà. Discutere. Discutere con chi la pensa diversamente da noi. Sempre in maniera pacifica ovviamente. Noi non dobbiamo discutere per ribattere, dobbiamo discutere per ascoltare, per capire. Dobbiamo capire per forza da dove partire e non cambieremo il mondo in una notte però questo è il secondo passo che possiamo fare. Supportare. Supportare vuol dire non creare delle nuove entità a meno che non abbiamo delle idee geniali e rivoluzionarie. Troviamo qualcuno che sta già lottando per la causa nella quale crediamo e supportiamolo. Noi non dobbiamo creare concorrenza, noi dobbiamo unirci e raggiungere un obiettivo. Ok? Quindi troviamo l’organizzazione che ci identifica, e poi devolviamo tempo ed energie per promuovere idee innovative e rivoluzionarie. Non aspettare. Perché in alcuni casi aspettare vuol dire accettare. Ed è sempre il momento giusto per fare la cosa giusta. Quindi agiamo ora, oggi, appena usciamo dal cinema ok? E infine ripetere, ripetere, ripetere, ripetere che è importante lottare per i diritti degli altri, ma è ancora più importante non lottare contro i diritti degli altri. Dobbiamo fregarcene dei diritti degli altri ci deve interessare dei diritti degli altri. Noi dobbiamo utilizzare il nostro status di privilegiati per favorire la libertà e la felicità a quante più persone possibili. Quello status di privilegiati non dobbiamo utilizzarlo per ostacolare il cammino di chi cerca di vivere una vita dignitosa. Grazie.